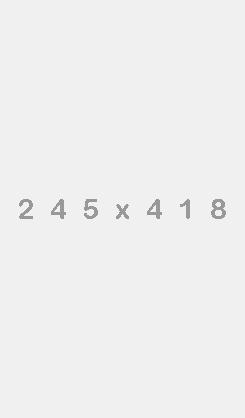In un Paese come l’Italia, da sempre circondato da mari, attraversato da fiumi e punteggiato da laghi, pensare a una crisi idrica può sembrare quasi paradossale. Per generazioni, l’acqua è stata considerata una risorsa abbondante, a portata di mano, sempre disponibile. Aprire un rubinetto e vederla scorrere limpida è stato un gesto tanto quotidiano quanto sottovalutato. Eppure, oggi, questo gesto sta diventando sempre più fragile, incerto, e in alcune zone già problematico. Non si tratta più di scenari futuri ipotetici, ma di una realtà che si sta già manifestando con segnali preoccupanti. E il tempo per intervenire si sta esaurendo.
Un'emergenza che ci riguarda da vicino con la cementificazione selvaggia della Pianura Padana
La Pianura Padana, che un tempo era una delle zone più fertili e idricamente ricche d’Europa, sta diventando simbolo della contraddizione tutta italiana tra sviluppo e dissennata gestione del territorio. A mettere in crisi il suo delicato equilibrio idrogeologico non è soltanto il cambiamento climatico, ma anche un altro nemico silenzioso: la cementificazione selvaggia.
Secondo i dati ISPRA (Rapporto sul consumo di suolo 2023), ogni anno in Italia vengono cementificati oltre 60 km² di suolo, e oltre un terzo di questa perdita avviene proprio in Pianura Padana. Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono tra le regioni con il più alto consumo di suolo pro capite. Capannoni, centri commerciali, lottizzazioni residenziali costruite spesso senza una reale pianificazione, hanno eroso campi, boschi e aree agricole che prima fungevano da spugne naturali, fondamentali per assorbire l’acqua piovana e ricaricare le falde.
Ora quei terreni sono sigillati. L’acqua non penetra più nel sottosuolo, ma scorre in superficie, sovraccaricando i canali, finendo rapidamente nei fiumi o evaporando. Il risultato? La faglia idrica della Pianura Padana si abbassa, le riserve si riducono, e il rischio di alluvioni e frane aumenta.
E c’è un paradosso: cementifichiamo i suoli agricoli e poi chiediamo più acqua per irrigare i campi superstiti. È una spirale distruttiva. Abbiamo tolto al territorio la sua capacità di autorigenerarsi, di trattenere e restituire lentamente l’acqua. Stiamo compromettendo non solo il paesaggio, ma la sicurezza alimentare e ambientale di un’area strategica per tutto il Paese.
Se davvero vogliamo combattere la crisi idrica, dobbiamo iniziare da qui: fermare il consumo di suolo, ripristinare gli spazi naturali, ripensare il nostro modello di crescita. Perché non può esserci acqua per tutti se continuiamo a costruire come se il suolo fosse infinito.
Negli ultimi anni, l’Italia ha vissuto estati sempre più calde, con piogge improvvise e violente che non nutrono il terreno ma lo erodono, e lunghi periodi di siccità che mettono in ginocchio fiumi, laghi e falde. Il Po, colosso fluviale del Nord Italia, ha toccato livelli mai registrati prima, diventando in certi tratti un letto secco. Il Lago di Bracciano, che serve la Capitale, è più volte sceso sotto i livelli di guardia. E mentre questi eventi si susseguono, le nostre reti idriche, vecchie e trascurate, continuano a perdere oltre il 40% dell’acqua potabile prima ancora che arrivi alle case. E tutti ci ricordiamo che in occasione del referendum per l'acqua alcuni decisori tendevano semplicemente a privatizzare il servizio e a giustificare la mancata manutenzione con il problema dei costi ("se anche ne perdiamo molta non ci costa, mentra la manutenzione quella si che ci costa!")
Parliamo di milioni di metri cubi di acqua sprecati ogni giorno. E non solo per colpa del clima: a causare questa emergenza è anche la nostra gestione inefficiente, frammentata, spesso miope di un bene che dovrebbe essere trattato come oro liquido. Invece, continuiamo a considerarlo scontato.
Acqua e agricoltura: un legame vitale in crisi
Se l’acqua comincia a scarseggiare, le prime a soffrire sono le colture. L’Italia, che basa gran parte della propria economia agricola sulla disponibilità di acqua dolce, sta già assistendo a una riduzione delle rese, all’abbandono di campi e alla perdita di varietà che richiedono irrigazione costante, come riso, ortaggi e frutta. La Pianura Padana, cuore produttivo del Paese, si sta desertificando a un ritmo che non può più essere ignorato.
Cosa succederà nei prossimi anni, quando alle esigenze dell’agricoltura si sommeranno quelle di una popolazione urbana sempre più concentrata nelle città, o quelle dell’industria e della produzione energetica? Il rischio di conflitti tra usi diversi dell’acqua è reale. E, a pagarne il prezzo, saranno sempre i più vulnerabili.
La tentazione di aspettare: un errore fatale
Troppo spesso, davanti a queste crisi, la reazione istituzionale è di tipo emergenziale. Si aspetta che il livello dei fiumi scenda, che i campi si secchino, che le autobotti diventino la norma in estate. Solo allora si corre ai ripari con soluzioni tampone, senza affrontare le radici del problema. Ma con il cambiamento climatico in accelerazione, questa strategia non è più sostenibile. Non possiamo più permetterci di rincorrere l’emergenza. Occorre prevenire, pianificare, agire ora.
Le soluzioni esistono. Ma richiedono coraggio politico e visione collettiva
Non mancano le soluzioni. Alcune sono già applicate con successo in altri Paesi, come Israele, che ha fatto del riuso delle acque reflue una risorsa strategica per l’agricoltura, o come la Spagna, che ha investito in sistemi di irrigazione intelligenti e invasi di stoccaggio. Anche in Italia, possiamo:
- Ristrutturare le reti idriche, riducendo le perdite con tecnologie di monitoraggio digitale.
- Recuperare e riutilizzare l’acqua piovana e reflua per usi agricoli e industriali.
- Promuovere un’agricoltura meno idrovora, introducendo sistemi a goccia, rotazioni colturali, varietà resilienti.
- Costruire bacini e micro-serbatoi per accumulare l’acqua in inverno e usarla d’estate.
- Educare i cittadini a un uso responsabile e premiare chi consuma meno, con tariffe intelligenti e giuste.
Tutte queste misure sono alla nostra portata. Ma richiedono scelte nette, investimenti continui e soprattutto una presa di coscienza collettiva. È finita l’epoca del “tanto l’acqua c’è”. Dobbiamo solo fare attenzione al "sentore di business" che tutte le emergenze provocano con la richieste di grandi opere (e altro cemento)
Se vogliamo davvero affrontare la crisi idrica, non possiamo affidarci solo a grandi opere infrastrutturali. Serve una rivoluzione diffusa, capillare, fatta anche di piccoli gesti urbani. Ecco perché introdurre micro-incentivi per la de-impermeabilizzazione delle città potrebbe rivelarsi una svolta efficace e popolare.
Comuni e Regioni potrebbero sostenere chi rimuove cemento da cortili e marciapiedi per creare aiuole, giardini filtranti o superfici drenanti. I parcheggi pubblici potrebbero essere resi permeabili con materiali innovativi, come l’asfalto poroso o le griglie erbose. Anche i tetti verdi, se incentivati, possono contribuire a trattenere e riutilizzare l’acqua piovana. Non si tratta di utopie, ma di interventi già sperimentati in molte città europee, spesso con risultati eccellenti.
L’obiettivo non è solo estetico: ogni metro quadrato restituito al suolo naturale contribuisce a ridurre i picchi di piena, ricaricare le falde e raffrescare l’ambiente urbano. Trasformare un parcheggio in un piccolo bacino assorbente può fare la differenza in caso di pioggia intensa. E se migliaia di cittadini potessero accedere a un bonus verde per contribuire alla resilienza del territorio, la battaglia contro la crisi idrica diventerebbe finalmente una sfida collettiva, concreta e partecipata.
Mediamente una città ha almeno 5 gradi in piu' rispetto alla campagna, questo divario dovrebbe diminuire.
La crisi idrica non è un problema del Sud globale o di qualche remoto deserto africano. È qui, sotto i nostri occhi, nelle nostre campagne, nei rubinetti delle nostre case. Continuare a ignorarla o a considerarla una questione per esperti equivale a scavare la fossa al nostro modello di vita, alla nostra economia, al nostro benessere quotidiano.
Il futuro dipende dalle scelte che faremo oggi. L'acqua è un diritto, ma solo se la trattiamo come un dovere.
Solo se cambiamo mentalità e pretendiamo un cambio di passo da parte delle istituzioni, potremo evitare che le prossime generazioni vivano in un Paese in cui l’acqua sarà davvero un lusso per pochi.